- Home
- Ordine
- Infermiere e Formazione
- Per gli Iscritti
- Libera Professione
- Modulistica
- News ed Eventi
- Contatti
Al via un’indagine sulle attitudini degli operatori sanitari verso la vaccinazione anti-Covid
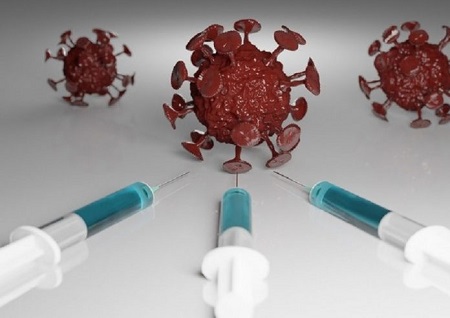
Al via un’indagine sulle attitudini nei confronti della vaccinazione anti COVID-19 tra gli operatori sanitari.
La Sezione di Igiene del Dipartimento Universitario Scienze della Vita e Sanità Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma sta promuovendo un’indagine volta a indagare conoscenze, attitudini e intenzioni nei confronti della vaccinazione anti COVID19 di diverse categorie di operatori sanitari nel territorio italiano.
Lo studio si inserisce nel contesto del Programma CCM 2020 Azioni Centrali e vede il coinvolgimento del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, come ente capofila, e del Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, come ente partecipante.
Il protocollo ed il questionario hanno ottenuto l’approvazione del Comitato Etico della Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” – Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Lo studio è condotto in accordo con i requisiti previsti dagli standard internazionali di buona pratica clinica (GCP) e alla Dichiarazione di Helsinki; i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e di tutta la normativa vigente in ambito di trattamento e protezione dei dati, nel pieno rispetto dei diritti e dell’anonimato dei partecipanti. L’indagine prevede la somministrazione di una web survey attraverso la piattaforma “SurveyMonkey”.
Questo strumento consente di inviare per via telematica il questionario attraverso un link. Aprendo il link la schermata principale visualizza il titolo del questionario, una descrizione dello stesso, l’informativa sulla privacy e l’acquisizione del consenso informato.
Se l’operatore sanitario accetta le condizioni, si apre una seconda schermata che consente di entrare nel questionario e di rispondere.
La procedura di raccolta del consenso informato, dunque, viene avviata prima dell’inizio del questionario, che può essere iniziato esclusivamente dopo aver accettato le condizioni.
Gli operatori sanitari dovranno, quindi, cliccare la casella apposita per accettare le condizioni. Chi rifiuta non può avere accesso al questionario.
L’operatore sanitario che accetta, deve compilare tutto il questionario, che ha una durata complessiva di circa 6 minuti. La compilazione del questionario avviene in forma anonima.
Obiettivo del progetto è raggiungere la massima diffusione su tutto il territorio e tra il maggior numero di professionisti sanitari e per questo è fondamentale il coinvolgimento degli ordini professionali.
Gli operatori sanitari sono una rilevante fonte di informazioni per il resto della popolazione, ed è dunque prioritario comprenderne le preoccupazioni e gli atteggiamenti sui vaccini anti COVID-19 per preparare strategie di comunicazione efficaci e basate sull’evidenza. www.fnopi.it
Affanno respiratorio da long Covid, parliamone con l’esperto Mauro Carone (AIPO)

La vita dopo Covid-19 non è uguale per tutti. Alcuni si riprendono in fretta e senza conseguenze, altri affrontano quello che è stato definito long Covid con sintomi a volte invalidanti che ricalcano quelli della malattia. I più frequenti in assoluto sono l’affanno respiratorio e la stanchezza, ma sono anche descritti dolori vari, muscolari, articolari, respiratori, perdita di olfatto e gusto, secchezza di occhio e bocca, senso di vertigine, sintomi cognitivi quali deficit dell’attenzione o della memoria, depressione ed ansia, annebbiamento mentale (brain fog), eruzioni cutanee, acufeni, tachicardia e perdita di capelli.
Dopo la sindrome da stanchezza cronica, affrontiamo il secondo fenomeno più riportato: l’affanno respiratorio o dispnea. Per fare luce Sanità Informazione ha incontrato il prof. Mauro Carone, presidente eletto AIPO (Associazione italiana pneumologi ospedalieri) e direttore dell’IRCCS Maugeri di Bari.
Long Covid e dispnea
Dopo Covid-19 la maggior parte dei pazienti recupera in 3-4 settimane, il 15-20% lamenta sintomi per tempi più prolungati (ongoing Covid infection), tra le 4-12 settimane. Dopo le 12 settimane si parla più propriamente di sindrome post Covid-19. Dalle quattro settimane in poi ciò che riferiscono i pazienti si può definire long Covid.
«L’affanno respiratorio, più propriamente la dispnea – spiega l’esperto – si manifesta come evidente difficoltà respiratoria. È descritta dai pazienti come fame d’aria, sensazione di non respirare adeguatamente, difficoltà a prendere fiato, fiato corto, dolore durante la respirazione».
In realtà, aggiunge, ogni paziente la riferisce in maniera differente: «Abbiamo persone con patologie importanti post Covid che hanno desaturazione da sforzo, quindi perdono ossigeno sotto sforzo, ma che hanno affanno scarsissimo. Altre che, in condizioni buone di saturazione, riferiscono affanno importante».
I pazienti più colpiti e l’eccessiva risposta immunitaria
L’affanno si può presentare anche in pazienti con un’infezione lieve e che non avevano necessitato di ricovero. «Le donne con meno di 60 anni di età hanno il doppio di probabilità di essere colpite da long Covid rispetto agli uomini di pari età, specie se affette da asma o altre malattie respiratorie croniche. Dopo i 60 anni però il rischio diventa simile a quello degli uomini». Età avanzata e sovrappeso influiscono allo stesso modo su chi rileva dispnea, così come la percentuale di persone che nei primi giorni di infezione ha riportato almeno cinque sintomi tipici.
«Quello che possiamo tentare di trattare è il danno d’organo causato dall’infezione da coronavirus, ad esempio il danno polmonare – specifica Carone -. Per il long Covid si ipotizza una eccessiva risposta immunitaria. Si pensa che il virus determini mimetismo molecolare, cioè abbia alcuni elementi in comune con componenti dell’organismo. A causa di ciò la risposta immunitaria contro il virus poi può rivolgersi anche contro alcuni organi o tessuti del nostro organismo, l’autoimmunità. Se questa ipotesi sarà poi confermata potrebbe anche spiegare la maggior frequenza di long Covid nelle donne, già normalmente maggiormente soggette a malattie autoimmuni».
«Per la dispnea persistente – aggiunge – vi è poi un’altra ipotesi: sembra che vi sia una particolare interazione tra la famosa proteina Spike del virus e le cellule presenti nelle vie aeree. Questa interazione potrebbe causare alterazioni prolungate dell’espressione genica delle cellule delle vie aeree e, conseguentemente, disturbi respiratori».
Curare o trattare l’affanno respiratorio
Si può curare questa fame d’aria e quanto dura? Sono queste le domande che tutti i pazienti che ne soffrono si pongono ogni giorno. «Ciò che mi sento di generalizzare è l’utilizzo di protocolli riabilitativi, soprattutto se gestiti tramite una equipe multidisciplinare. In particolare, l’uso di esercizi aerobici nel long Covid può migliorare l’immunità e la funzionalità respiratoria. Sono altresì utili esercizi di respirazione controllata in grado di ridurre il livello di dispnea, gli esercizi di mobilizzazione e di rinforzo dei distretti articolari».
Nella maggior parte dei casi l’affanno respiratorio è un disturbo temporaneo, rassicura il presidente eletto AIPO. Resta opportuno però rivolgersi al proprio medico curante e, su sua indicazione, a una clinica long Covid. Oppure alle strutture dove è stato istituito un Day Service ambulatoriale (PACC Percorso ambulatoriale complesso e coordinato) dedicato al follow up nel tempo dei pazienti post-Covid. Come avviene a Bari dove opera il prof. Carone.
Qui si valuterà la necessità di ossigenoterapia, di riabilitazione, di supporto psicologico per i pazienti con disturbi neurocognitivi o simili al disturbo da stress post traumatico. Nonché l’utilità di farmaci specifici quali gli steroidi, gli anticoagulanti, gli antibiotici e gli antifibrotici.
«Ai pazienti – conclude l’esperto – dico che non bisogna disperare, ma chiedere aiuto. Ai colleghi professionisti che dobbiamo prendere in carico meglio il paziente per aiutarlo a recuperare tutte le proprie funzioni, ascoltarlo fino in fondo». www.sanitainformazione.it
Infermieri e coordinatori di ricerca figure centrali della sperimentazione clinica: emendamento al Dl Semplificazioni

Arriva una modifica alla legge Lorenzin (legge 3/2018): i criteri con cui il Governo deve esercitare la delega legislativa sulla sperimentazione clinica devono prevedere una maggiore semplificazione della disciplina.
E tra le professionalità specifiche nel campo della gestione dei dati e del coordinamento della ricerca di cui deve avvalersi la sperimentazione clinica dei medicinali saranno ricompresi anche l’infermiere coinvolto nell’esecuzione della sperimentazione clinica e il coordinatore di ricerca clinica.
A stabilirlo è un emendamento (64.09) appena approvato dalle Commissioni I (Affari Costituzionali) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) al decreto Semplificazioni bis, a firma della stessa Lorenzin e di altri deputati Pd (Rizzo Nervo, Carnevali, Raciti, D’Attis), che semplifica anche le procedure in attesa dell’implementazione del regolamento europeo sulla ricerca clinica.
Tra le semplificazioni è previsto che sia evitata la richiesta di ulteriore documentazione accessoria per la valutazione degli studi clinici e sia semplificata con un modello nazionale vincolante la certificazione della idoneità delle strutture per la partecipazione allo studio clinico.
Infine, è previsto l’inserimento della ricerca clinica tra gli argomenti oggetto di formazione e formazione continua per le professioni sanitarie. www.fnopi.it
