- Home
- Ordine
- Infermiere e Formazione
- Per gli Iscritti
- Libera Professione
- Modulistica
- News ed Eventi
- Contatti
Pillole di Wound Care: la Pressione Topica Negativa.
 Quando sulle lesioni di difficile guarigione le medicazioni avanzate non funzionano esistono diverse possibilità che vengono in aiuto del paziente e di chi se ne prende cura. Come in tutti i campi la tecnologia avanza (per fortuna) e la vulnologia ha fatto diverse tecniche nate in altri ambiti della medicina. Una di queste è la pressione topica negativa (NPWT). L’impiego clinico della pressione negativa risale a migliaia di anni fa. Essa è stata usata per la prima volta nella medicina cinese in aggiunta alle tecniche di agopuntura. Molto più tardi, nel 1841, venne adottato il metodo usando coppette di vetro riscaldate applicate alla cute del paziente per “stimolare la circolazione”. È entrata nel mercato europeo nel 1994 con il nome di V.A.C. Therapy (vacuum assisted closure) e oggi è largamente utilizzata in ambito ospedaliero per la gestione delle lesioni di difficile guarigione di diversa eziologia e nell’ambito della prevenzione chirurgica.
Quando sulle lesioni di difficile guarigione le medicazioni avanzate non funzionano esistono diverse possibilità che vengono in aiuto del paziente e di chi se ne prende cura. Come in tutti i campi la tecnologia avanza (per fortuna) e la vulnologia ha fatto diverse tecniche nate in altri ambiti della medicina. Una di queste è la pressione topica negativa (NPWT). L’impiego clinico della pressione negativa risale a migliaia di anni fa. Essa è stata usata per la prima volta nella medicina cinese in aggiunta alle tecniche di agopuntura. Molto più tardi, nel 1841, venne adottato il metodo usando coppette di vetro riscaldate applicate alla cute del paziente per “stimolare la circolazione”. È entrata nel mercato europeo nel 1994 con il nome di V.A.C. Therapy (vacuum assisted closure) e oggi è largamente utilizzata in ambito ospedaliero per la gestione delle lesioni di difficile guarigione di diversa eziologia e nell’ambito della prevenzione chirurgica.
“Pressione negativa” è un termine che designa una pressione inferiore a quella atmosferica normale di 760 mmHg. Con l’acronimo NPWT (negative pression wound terapy), si identifica la tecnica che utilizza la pressione negativa applicata al wound care. Il razionale su cui fonda è che la pressione negativa rimuove i fluidi extra cellulari e l’essudato, riduce l’edema e migliora il flusso sanguigno locale, fornendo così l’ossigenazione e il nutrimento ai tessuti nel sito della lesione, riducendo la carica batterica, accelerando infine la granulazione del fondo di lesione.
Esistono ormai diverse aziende che producono apparecchi in grado di gestire praticamente ogni tipo di lesione, dalle più piccole e superficiali alle profonde e cavitarie. Utilizzabili in ambito ospedaliero da personale specializzato ma anche a domicilio.
In generale il meccanismo è composto da un riempimento in schiuma di PU (Poliuretano) o garza che occupa la cavità della lesione e all’interno della quale viene inserito un tubo di drenaggio; il tutto è sigillato con una pellicola adesiva. La pellicola gas-permeabile permette lo scambio gassoso e allo stesso tempo protegge la ferita mentre il tubicino convoglia la pressione negativa al sito lesionale.
Una volta applicata la medicazione viene attivata la pompa che crea il vuoto attraverso l’erogazione di pressione con valori compresi fra -200 mmHg e -25 mmHg in base al tipo di apparecchiatura utilizzata, alla lesione e alla tolleranza del paziente.
A seconda del tipo di ferita, della sede anatomica della stessa e al paziente trattato, la pressione può essere applicata continuamente o in modo intermittente. Esistono anche dei sistemi che instillano in misura controllata prodotti antisettici e antibatterici direttamente sulla ferita.
Gli effetti più interessanti di questa procedura sono la Macrodeformazione e la Microdeformazione: la prima è lo stiramento visibile che avviene quando la pressione negativa contrae la schiuma, serve ad avvicinare i lembi della ferita, permette un contatto diretto e completo con il letto della ferita, distribuendo uniformemente la pressione. Mentre la Microdeformazione è la deformazione a livello cellulare, che porta ad uno stiramento delle cellule riducendo l’edema, promuovendo la perfusione, aumentando la proliferazione e la migrazione cellulare, promuovendo la formazione di tessuto di granulazione.
L’utilizzo della NPWT è controindicato invece in presenza di ferite con escara, osteomeliti non trattate, fistole non enteriche e non esplorate, lesioni neoplastiche, esposizioni di vasi e nervi, esposizione di anastomosi, esposizione di organi.
Questi sistemi integrati sono sicuramente costosi (anche se sempre più competitivi) ma è necessario ragionare in termini di tempi di guarigione, soddisfazione del paziente ed efficacia della terapia in un campo di applicazione in cui i tempi di gestione della lesione con le tecniche di medicazione tradizionali possono essere molto lunghi e incidere negativamente sulla qualità della vita del paziente e sulla spesa globale per l’assistenza.
Opi Teramo a Scuola
 Si informa che Venerdì 7 Ottobre, alle ore 10, una delegazione di Consiglieri sarà presente presso l'Istituto Di Poppa di Teramo per incontrare gli studenti del primo anno al fine di sostenere una lezione di primo soccorso.
Si informa che Venerdì 7 Ottobre, alle ore 10, una delegazione di Consiglieri sarà presente presso l'Istituto Di Poppa di Teramo per incontrare gli studenti del primo anno al fine di sostenere una lezione di primo soccorso.Leadership emotiva. L’uso dell’intelligenza emotiva nel coordinamento.
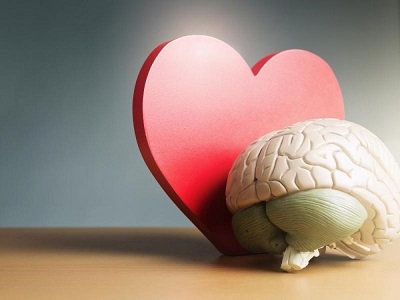 "Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione ignora" (Pascal)
"Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione ignora" (Pascal)
È innegabile che l’uomo sia costituito da “mente e cuore” e che nell’evoluzione umana, le emozioni abbiano consentito uno stimolo alla sopravvivenza della specie tanto da imprimersi nel nostro sistema nervoso. È nel R-Complex (o cervello rettiliano) che risiedono le emozioni e nell’amigdala la gestione delle stesse, chiamata intelligenza emotiva.
Se gli antichi romani ritenevano una virtù, tanto da definirla “dono dello spirito santo”, la temperatia (capacità di tenere a freno gli eccessi emozionali), ai nostri giorni possiamo definire l’intelligenza emotiva la capacità di comprendere, utilizzare e gestire le proprie emozioni in modo positivo, comunicare in modo efficace e disinnescare i conflitti.
È proprio sull’intelligenza emotiva che si basa una forma di leadership che sta attirando l’attenzione internazionale cioè la leadership emotiva, una leadership che si fonda su concetti neurologici: gli stati d’animo, le emozioni del leader e i comportamenti consequenziali che influenzano le persone che dipendono da lui.
Per quanto nella letteratura infermieristica italiana tale tema venga poco trattato, in tutto il modo, in particolar modo a seguito della pandemia, si sta osservando la stretta correlazione tra coordinatori infermieristici dotati di una sviluppata intelligenza emotiva e benessere lavorativo all’interno delle unità che quest’ultimi dirigono.
Va ricordato che una delle migliori qualità di cui un infermiere deve essere dotato è l’empatia. L’empatia è la capacità di comprendere gli stati d’animo, i comportamenti e le emozioni altrui. Tale capacità permette di istaurare buone relazioni con gli altri, più durevoli, attive e stabili. Se come diversi studi dimostrano l’empatia e l’intelligenza emotiva sono strettamente connesse l’una all’altra, ne deriva da sé che un infermiere che diventa coordinatore di un’unità che preserva e sviluppa questa qualità facendola propria può diventare da capo a leader con ottime capacità. Se infatti nella figura dei leader in generale il personale è alla ricerca di un riferimento che rassicuri e guidi il personale al raggiungimento degli obiettivi, nel leader emotivo si ricerca in aggiunta un contatto che possa dare un sostegno emotivo, di empatia.
Alla luce di quanto appena detto è importante sottolineare che coordinatori molto preparati ma con una scarsa intelligenza emotiva possono certamente compensare tale mancanza facendo affidamento sul loro intelletto e facendo forza sulla posizione formale, ma così facendo spesso esasperano la loro debolezza e quella altrui. Infatti molto spesso prendere punti di forza in prestito crea debolezza in noi stessi, negli altri e dunque anche nelle relazioni.
La letteratura evidenzia come i leader infermieristici con intelligenza emotiva sviluppata riescono a creare un clima lavorativo centrato sulla fiducia reciproca e creare un clima lavorativo che permette alle persone di dare il meglio di sé (Akerjordet e Severinsson, 2007) e di gestire i conflitti, creando un’opportunità per migliorare le abilità interpersonali (Morrison, 2008). Le abilità sociali favoriscono la collaborazione e il senso di appartenenza, migliorando i rapporti e creando un clima di gruppo favorevole alle espressioni emozionali.
In un momento storico in cui la fuga di infermieri va per la maggiore e dove c’è sfiducia anche generata dal passaggio da eroi a ….il nulla! Forse un po’ di leadership emotiva ci vorrebbe, insomma un po’ di Annibale che guidino le loro unità con un “Noi troveremo una strada, oppure ne apriremo una”.